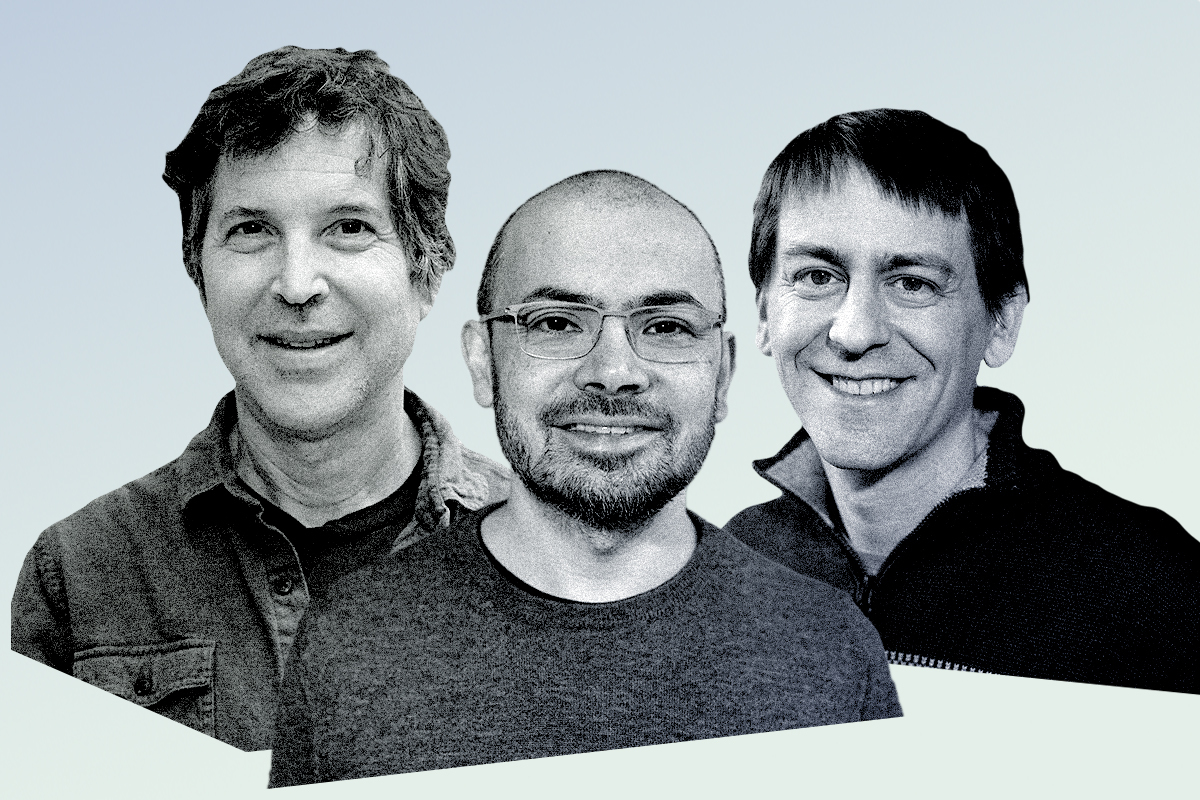Ieri sera, in una chiesa di Cotacachi, sono stati rilasciati quattro dei 17 soldati tenuti prigionieri dalle comunità indigene da domenica. Una tregua, certo, ma la processione interna continua: 13 bambini rimangono dentro, la rabbia per lo sciopero nazionale non si placa e si parla di un morto. Il conflitto in Ecuador è tutt'altro che placato; anzi, sembra che ogni giorno si aggiunga benzina sul fuoco.
La notizia del loro rilascio è stata un balsamo in mezzo a tanta tensione. È stato l'esercito stesso a confermare che i quattro soldati erano stati consegnati lunedì sera, verso le otto, presso la chiesa di San Francisco. Sembrava un terreno neutrale, per un gesto volto a decomprimere, ma che ha lasciato più domande che risposte. Non appena se ne sono andati, i ragazzi si sono subito sottoposti a un controllo medico per vedere come stavano dopo il loro calvario. Degli altri 13 che rimangono detenuti, non c'è stata una sola parola ufficiale. Un silenzio assordante che aggiunge pepe all'incertezza delle famiglie e di un intero Paese che osserva da vicino quanto sta accadendo nella provincia di Imbabura.
Un "rapimento" nel mezzo del conflitto in Ecuador
Per il governo di Daniel Noboa, la situazione è chiara e non ci sono zone d'ombra: si è trattato di un "rapimento". Infatti, l'esercito non ha perso tempo e ha presentato una denuncia formale alla Procura, che ha deferito il caso a un'unità specializzata per la criminalità organizzata transnazionale. Scartoffie, timbri e burocrazia si susseguono, mentre le strade sono in fermento. Ma per comprendere il quadro completo, bisogna fare un passo alla volta e tornare indietro.
I soldati non stavano semplicemente passeggiando per Cotacachi. Facevano parte di un gruppo di 50 soldati a guardia di un convoglio che, per molti, aveva solo il nome di un'operazione umanitaria. Si trattava di una carovana di circa 100 veicoli, sia militari che civili, guidata dallo stesso presidente Noboa e da diversi suoi ministri. Un dispiegamento che, nell'epicentro delle proteste, sembrava più una dimostrazione di forza che una semplice consegna di aiuti. Fu allora che circa 350 persone, secondo i dati ufficiali, bloccarono il loro cammino. La situazione degenerò rapidamente: molotov furono lanciate contro i veicoli e, nel caos, i 17 soldati finirono prigionieri dei manifestanti.
Due storie, una morte e un paese diviso
E quello stesso giorno, in quello stesso luogo, la storia si è macchiata di sangue. Efraín Fueres, membro di una comunità indigena, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dalle forze di sicurezza . È diventato così la presunta prima vittima di questo sciopero indetto dalla Confederazione delle Nazionalità Indigene dell'Ecuador (CONAIE), che da nove giorni paralizza le strade e infiamma gli animi. Da qui, la storia si divide in due, come il Paese stesso.
Da un lato, la CONAIE e le organizzazioni di base non parlano di scontro, ma piuttosto di "massacro pianificato" e di "crimine di Stato". Denunciano l'uso da parte dei militari di "munizioni vere, dinamite e armi letali" contro la popolazione. Per loro, la detenzione dei soldati non è un sequestro di persona, ma una misura disperata in risposta alla repressione che subiscono sul loro stesso territorio.
D'altro canto, il Ministero della Difesa ha una sua versione dei fatti. Segnala almeno dodici soldati feriti dall'inizio dell'attacco e presenta il suo personale come vittima di una violenta imboscata. Due versioni si scontrano frontalmente, senza ponti in vista e con un'indagine giudiziaria che deve stabilire chi sta dicendo la verità in questo pasticcio.
La tensione non si allenta e il mondo guarda con sospetto
Nel frattempo, dall'esterno, la situazione è vista con palese preoccupazione. Attraverso il suo portavoce, il leader delle Nazioni Unite António Guterres ha già espresso la sua "profonda" preoccupazione per la spirale di violenza che sta sfociando nel conflitto in Ecuador , menzionando specificamente la morte del leader della comunità. Un gesto diplomatico che invita tutte le parti a rallentare, garantire il "pieno rispetto dei diritti umani" e sedersi al tavolo delle trattative per risolvere le controversie "attraverso un dialogo inclusivo".
Una richiesta che sembra logica da una scrivania a New York, ma sulle strade dell'Imbabura sembra un'utopia. Lo sciopero continua, le rivendicazioni delle comunità indigene su questioni economiche e territoriali non si sono mosse di un millimetro e la posizione del governo sembra rifiutarsi di cedere alle pressioni.
Allo stato attuale, la liberazione dei quattro soldati è solo un capitolo di un romanzo che sembra tutt'altro che concluso. Con 13 soldati ancora nelle mani dei manifestanti, una morte che pesa come una tonnellata sulla coscienza del Paese e due narrazioni inconciliabili, il futuro immediato è incerto. La gente comune, coloro che lavorano ogni giorno e vedono il prezzo della yerba mate, del pane e del latte a causa dei blocchi, sono quelli rimasti nel mezzo, in attesa che la tempesta passi. Ma per ora, in Ecuador, tutto ciò che resta è una nuvola scura.